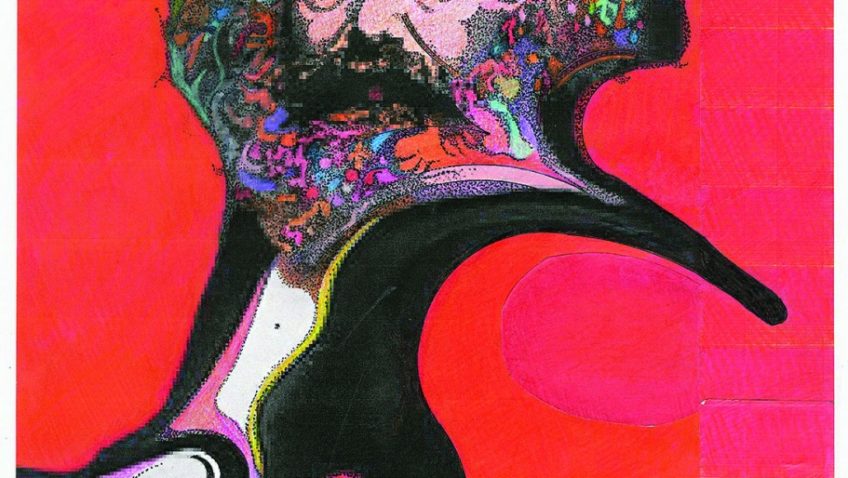Qualche anno fa, recensendo il bel libro di Enzo Traverso Il secolo armato. Interpretare le violenze del Novecento (Feltrinelli, 2012), richiamavo l’opportunità di aggiungere alle violenze legate alle guerre e ai regimi totalitari, da lui esplorate con molto acume, quelle «industriali». A partire dal regime di fabbrica, intessuto di violenza e gangsterismo padronali, che dominava tra le due guerre alla Ford, un caso che Traverso citava invece come esempio di classe operaia che già negli anni Trenta «conosceva il lusso» di «appartamenti dotati non solo di un bagno ma anche di riscaldamento centralizzato, telefono, frigorifero, lavatrice e televisore, compresa un’auto in garage». Di queste e altre violenze, concludevo, oltre che di quelle più note e visibili di natura politica, è «materiato» il Novecento e sarebbe bene incorporarle nei «discorsi» sul secolo. Lo straordinario libro di James R. Green The Devil Is Here in These Hills. West Virginia’s Coal Miners and Their Battle for Freedom (New York, Atlantic Monthly Press, 2015, pp. 440, $28) proprio di questo parla. È la storia di come i minatori del West Virginia hanno strappato il diritto alla libertà di organizzazione e di presa di parola passando attraverso decenni di lotte durissime, da fine Ottocento ai primi anni Quaranta del secolo successivo. Lo hanno fatto, mostra Green in pagine che dovrebbero essere adottate nelle scuole di ogni ordine e grado, ma in particolare dove si studia diritto, ricorrendo in certi casi alla violenza organizzata e collettiva per rispondere al regime autoritario e dispotico, alle violenze e alle violazioni sistematiche della legalità da parte degli imprenditori e delle autorità politiche di vario livello spesso impegnate a dar man forte al capitale. Tant’è vero che dapprima nel 1912–13 e di nuovo un decennio dopo, nei primi anni Venti, si parla di vere e proprie «guerre minerarie».
«Guerre», sottolinea opportunamente Green, che sono andate perdute nella memoria collettiva d’oltre Atlantico e che figurano solo di sguincio anche nei libri di storia del lavoro. Forse perché, osserva, gli studiosi che simpatizzano per la causa del lavoro «tendono a focalizzare la loro attenzione su incidenti nei quali gli scioperanti erano vittime di violenza» e «sono riluttanti a gettare troppa luce su ciò che è avvenuto quando gli scioperanti imbracciavano i fucili per combattere contro le di solito superiori forze armate mobilitate dagli imprenditori». Ecco allora l’attenzione concentrata su sanguinose sconfitte operaie come lo sciopero ferroviario generale del 1877, la vicenda di Haymarket da cui origina il Primo maggio (al quale Green stesso ha dedicato il bellissimo e molto apprezzato Death in the Haymarket, Pantheon Books, 2006), lo scontro siderurgico di Homestead del 1892, il massacro minerario di Ludlow del 1914. E, per converso, la tendenza a dimenticare il West Virginia, che per giunta si porta dietro lo stigma, che noi ben conosciamo per i grandi studi di Alessandro Portelli su altri minatori appalachiani, di un’«arretratezza» congenita. Di Portelli e della sua formidabile lezione di ricerca mi ha parlato costantemente Green tutte le volte che ci siamo visti nei lunghi anni che gli sono occorsi per scrivere questo libro. Il suo primo contatto col West Virginia risale al 1978, quando, incaricato di scrivere un articolo militante su uno sciopero allora in corso, si rivolse al padre della «nuova storia del lavoro», David Montgomery, che all’epoca insegnava a Pittsburgh e che lo indirizzò a un suo dottorando di quell’area. Cominciava così un rapporto con le miniere del West Virginia che non si è mai interrotto, anche se nel frattempo Green, che adesso è professore emerito alla University of Massachusetts dopo averci insegnato per decenni, si è occupato di numerose altre questioni di storia del lavoro: dai socialisti dell’Oklahoma, all’uso pubblico della storia, ai «martiri di Chicago». Finché qualche anno fa ha ripreso in mano questa vicenda con l’idea di scrivere un libro da studioso ma che potesse indirizzarsi anche a un pubblico più generale.
Dal grande al piccolo schermo
Il risultato, dopo anni di vasta ricerca e di non meno vasta revisione, sono queste oltre quattrocento pagine, un settimo delle quali fitte di note, che si leggono come un romanzo perché la materia è da romanzo o da film. In effetti di un episodio di questa storia, lo scontro che nel luglio 1921 vide il coraggioso sceriffo (e pistolero provetto) favorevole ai minatori Sid Hatfield soccombere sotto i colpi dei sicari imprenditoriali, si è occupato il regista John Sayles nel western operaio Mathewan(1987). Dalla seconda di copertina del libro Sayles assicura che «The Devil Is Here in These Hills è la più comprensiva e comprensibile storia delle guerre del carbone del West Virginia che io abbia letto». Gli fanno eco, dalla quarta di copertina, studiosi del calibro di Elliott Gorn e Glenda Gilmore. Ma anche il mondo della televisione si è interessato al libro e alla sua storia, come dimostra il fatto che la sezione di Boston della Pbs, la tv pubblica d’oltre Atlantico, ha comprato i diritti per realizzare un documentario tratto da The Devil. Il titolo del libro, con quell’allusione al «diavolo» che abita nelle colline del West Virginia, è tratto da una frase di un ex-imprenditore e poi isolato politico progressista che nel 1912 così stigmatizza il comportamento predatorio dei padroni delle miniere nei confronti dei loro lavoratori, sottolineando come «Dio non cammina in queste colline». L’espressione adombra la forte religiosità che permea, come ci ha insegnato Portelli, gli Appalachi, la vasta regione degli Stati Uniti distesa per quasi quattrocento contee e tredici stati, lungo l’omonima catena montuosa che taglia trasversalmente il paese, con al centro l’hinterland di alcuni stati del Sud: appunto West Virginia, Kentucky, Tennessee e Alabama. È una religiosità che ritroviamo oltre vent’anni dopo quando, di fronte all’avanzata del sindacato nel clima di profondo rinnovamento sociale del New Deal, la figlia di un minatore prorompe in un canto di vittoria che dice: «Signore, signore siamo indipendenti ora/ ora quando incontri il padrone non devi inchinarti/ non è un re — non lo è mai stato in alcun modo». Tra questi versi e la frase del politico del primo Novecento ci sono le due «guerre» che vedono datori di lavoro e minatori gli uni contro gli altri armati, sullo sfondo delle alterne fortune dell’industria del carbone, un settore attraversato dalla costante tensione, ma anche dalle convergenze e integrazioni funzionali, fra le piccole imprese a base locale e le grandi corporations nazionali. È un contesto nel quale spicca l’incessante spinta padronale al taglio dei costi da lavoro, per incrementare i margini di profitto fisiologicamente limitati, e al rigido controllo sociale attraverso la formula predatoria della company town. In essa tutto appartiene al padrone, il salario è erogato almeno in parte in buoni redimibili solo presso lo spaccio imprenditoriale, le malsane catapecchie operaie sono di proprietà dell’impresa che può espellere i dipendenti-inquilini a proprio piacimento, lo spazio fisico e mentale dei lavoratori è ridotto all’osso.
Lo stigma dello stereotipo

Eppure, seguendo attraverso una miriade di fonti, lavoratori, imprenditori e resto della comunità, Green mostra come anche in queste terribili condizioni chi lavora riesca a trovare il coraggio per alzare la testa, superare le divisioni fra nativi di lingua inglese, migranti calabresi e minatori afroamericani venuti dal Sud, segmenti di forza lavoro tanto diversi e che i proprietari delle miniere cercano in ogni modo di giocare gli uni contro gli altri. Le «guerre» scoppiano non perché, come suggerisce cedendo a uno stereotipo nazionale su queste zone il «New York Times» nel 1921, siamo in presenza del «montanaro primitivo» che conosce solo la legge del taglione e della foresta. Legge testimoniata, a dire dell’autorevole foglio, dalla lunga, atavica tradizione delle faide famigliari scoppiate in West Virginia sin dal Sette-Ottocento. Ma al contrario, dimostra bene Green, le «guerre» scoppiano per la ferrea opposizione che i tanto «moderni» imprenditori oppongono all’introduzione in queste aree di una «modernità» politica a loro sgradita, quella della libera rappresentanza delle parti sociali, del trasferimento in sede economica dello spirito di un’autentica cittadinanza allargata. È l’opposizione inveterata a questo, al tentativo di portare la Dichiarazione d’Indipendenza e magari anche un po’ di socialismo fra i boschi del West Virginia che arma le milizie padronali, così come gli sceriffi e i politici statali infeudati ai grandi interessi economici che mandano le truppe della Guardia nazionale, quando non bastano i privati, a sparare sui lavoratori. I quali a loro volta si mobilitano, seguendo l’invito proveniente da Mother Jones, l’indomabile anziana organizzatrice di origine irlandese. Stando al resoconto di un giornale locale, nel 1913 — di fronte alla barbara uccisione di un minatore, Cesco Estep, reo solo si essersi ribellato all’ordine di evacuazione della sua casa a opera degli sgherri padronali — Jones «saluta Cesco nella sua strada verso il cielo» e poi, rivolta a chi è rimasto, gli intima di prendere il fucile e «mandare i responsabili all’inferno».
Lezioni per il presente
Fra i minatori emergono militanti sindacali socialisti come Frank Keene che, forte della sua diretta esperienza in miniera, per decenni tesse la tela dell’organizzazione, dentro, fuori, a lato del grande, ma a tratti, a livello nazionale, controverso e compromissorio, sindacato industriale, comprendente cioè lavoratori qualificati e non, della United Mine Workers of America. Emergono le donne che fanno comunità e partecipano a pieno titolo alle lotte. Emergono l’idea e la pratica di una democrazia vissuta come aspirazione quotidiana e in continua evoluzione che si proietta dai margini economici e politici del paese verso il suo centro per scuoterlo. Come conclude Green, «durante la loro marcia verso la libertà, i minatori organizzati del West Virginia e le loro famiglie assunsero degli enormi rischi e fecero grandi sacrifici. Lo fecero perché compresero che cosa una vittoria poteva significare per loro, per le loro famiglie, per i loro vicini e per i loro compagni nelle miniere». Ma contemporaneamente «la loro lotta allargò e approfondì il significato della libertà in tutta l’America industriale». Una libertà, va ribadito, come pratica relazionale e collettiva che parte non dalla miope prigione della sovranità individuale, ma dalla comune esperienza sul luogo di lavoro. Di fonte al modo col quale il lavoro è svilito oggi sotto tutte le latitudini rileggere queste pagine di una storia apparentemente tanto lontana pare qualcosa di più di un semplice esercizio antiquario. Interroga la nostra capacità quotidiana di rispettare noi stessi.