Condannate come esperienze arcaiche, le pratiche sociali «benicomuniste» sfuggono alla forme della politica moderna senza rinunciare alla scommessa di poter produrre nuove e innovative istituzioni. Un intervento sul festival internazionale dedicato a questo tema che si terrà a luglio in Piemonte
Far riemergere il «comune» dalla doppia damnatio memoriae della storia è operazione culturale e politica di grande rilevanza e forte potenziale trasformativo. I commons sono stati schiacciati all’epoca delle enclosurese dell’accumulazione primitiva dalla grande tenaglia della modernità giuridica e politica. La storia, scritta dai vincitori, li ha resi oggetto di dileggio, tacciandoli di nostalgia, di oscurantismo di incapacità di innovazione. La stessa locuzione «luogo comune» indica banalità e ripetitività. Il comunismo mai realizzato ma solo promesso dall’esperienza socialista di Stato ha dato il colpo di grazia al prestigio del comune. Il saggio «La tragedia dei beni comuni» del biologo Garrett Hardin non ha fatto che radicare sempre più l’idea, presente fin dai tempi delle critiche di Aristotele a Platone, secondo la quale ciò che è gestito in comune non può che essere gestito male. La grande crisi ecologica in cui il mondo è caduto ha ridato dignità ai beni comuni anche in Occidente e ha messo al centro della scena un grande progetto di ricostruzione di istituzioni capaci di costruire dal basso un mondo che sia davvero un «luogo comune».
Comunità ibride
La partita aperta ora è quella di mettere a sistema la tantissime esperienze di comunità che si riconoscono consapevolmente o meno nel cammino «benicomunista». Sono oggi in campo pratiche collettive assai numerose che pur nella loro grande diversità attuano in tutto o in parte una visione di comunità aperta capace di soddisfare bisogni reali di condivisione, socializzazione e spiritualità. Le comunità in lotta per i beni comuni sono caratterizzate da alcuni tratti. Esse non sono coerenti né col principio di territorialità (una forte esperienza politica territoriale si ha tuttavia in Val Susa) né sono meramente comunità di produzione specialistica, come le corporazioni medievali. Esse sono ibride nella struttura, spesso generaliste negli interessi, e quasi sempre al loro interno i compiti sono distribuiti in modo interscambiabile. Ciascuna di esse approfondisce conoscenze e vanta competenze tecniche traducibili in piattaforme politiche. Chi solidarizza coi migranti produce una politica estera; chi lotta contro le «grandi opere» sviluppa una politica dei lavori pubblici e dei trasporti; chi pratica lo scambio solidale sviluppa una visione di politica commerciale; chi occupa teatri elabora una politica per i beni culturali.
La pratica del consenso
Varia il tasso di politicizzazione e di soggettività consapevole, nonché il rapporto con le istituzioni costituite. Tuttavia queste comunità condividono e negoziano continuamente i propri fini attraverso pratiche di democrazia partecipativa profondamente egualitarie. La democrazia diretta e partecipata che esse sviluppano, a differenza dei diversi modelli di rappresentanza, non condivide il feticismo della maggioranza né il culto della meritocrazia, intesa come processo virtuoso di selezione del leader più carismatico. Le pratiche politiche «benicomuniste» mirano al consenso unanime o quasi unanime nelle scelte fondamentali che sono sempre genuinamente collettive, ma lasciano al contempo spazio a ogni soggettività e sensibilità, talvolta anche idiosincratica, di interpretare in autonomia il senso profondo condiviso dell’esperienza «benicomunista». Esse inoltre assumono forme organizzative, formali o informali, che valorizzano la presenza, lo scambio continuo, la condivisione del progetto di vita, sia che esso possa essere effettivamente condotto assieme (per esempio nelle occupazioni di spazi abitativi) che nelle ipotesi in cui ciascun «comunardo» mantenga propri legami ed un proprio lavoro. Nella politica di comunità poi, a differenza che nelle organizzazioni burocratiche pubbliche o private, i singoli non sono confusa con lo specifico ruolo che svolgono, ma sono considerati per la loro singolarità.
Certo, le capacità professionali spesso sono utili e valorizzate, tuttavia mai esse creano nella fisiologia della comunità, condizioni gerarchiche, perché l’esperienza del comune è il miglior vaccino contro la dominazione. Ovviamente la patologia può sempre insorgere, ma normalmente l’esito è la decadenza e l’irrilevanza politica dell’esperienza comunitaria che si «ammala» di leaderismo o di auto-referenzialità. Le esperienze di comunità in lotta non sono mai chiuse. A differenza delle organizzazioni politiche di partito che «competono» per il potere esse non sono mai eccessivamente identitarie perché il «benicomunismo», non è esperienza di partito, non compete contro altri gruppi, cercando semmai di contaminarne le pratiche e può vincere soltanto se dal basso, tutti insieme, si vince. Una parte dello sforzo di quanti fanno comune è dedicato proprio al collegamento con altre realtà di cui condividono gli scopi al fine di solidarizzare o di mettere a sistema risorse o esperienze. Sempre più spesso si sviluppano rapporti internazionali che possono perfino produrre eccezionali riconoscimenti di eccellenza, come nel caso del Teatro Valle premiato dalla European Cultural Foundation o del Colorificio di Pisa portato ad esempio di buona pratica di produzione inclusiva dal Consiglio d’Europa.
Ciò che ancora manca è un quadro di collegamento collettivo istituzionalizzato, la costruzione reale di una «comunità di comunità» capace di rendere effettivamente incisivo sul piano generale la nuova soggettività politica «benicomunista».
In cerca di egemonia
Occorre dunque risolvere il problema della strutturazione politica della «comunità di comunità». Quando le condizioni sono davvero mature, come nella «Barcellona en comù», si sanno sperimentare soluzioni nuove evitando fughe in avanti ma anche immobilismo e incapacità reattiva. Probabilmente anche in quest’ambito saranno esperienze pilota, parziali e provvisorie, ad aprire la via. Che ciò sia politicamente fattibile è stato dimostrato dall’esperienza dei referendum «benicomunisti» del giugno 2011 che hanno saputo raggiungere una maggioranza degli italiani attraverso l’azione di attivisti sparsi su tutto il territorio e legati fra loro unicamente da un ideale condiviso. Tradurre questo successo di single issue politics in una potenziale alternativa politica a tutto tondo è la sfida dei prossimi anni. Si tratta di una partita difficile e complessa perché, proprio come la battaglia sull’acqua pubblica, essa può vincersi soltanto con alleanze e parole d’ordine costituenti, che non possono essere decifrate con gli strumenti tradizionali della teoria politica e delle sue schematiche contrapposizioni fra destra e sinistra.
Se la visione del comune e le pratiche che sapremo mettere in campo sapranno conquistare l’egemonia, vivremo nei prossimi anni una entusiasmante fase costituente di segno opposto rispetto al tetro tentativo restauratore che la politica ufficiale chiama riformismo. Non possiamo stupirci che con ogni mezzo, assai spesso disonesto sul piano tanto politico quanto intellettuale, si cerchi di delegittimare un cammino condiviso, onesto e coraggioso, quello del «benicomunismo», che colpisce la rendita in ogni sua forma. Dobbiamo valorizzare le nostre buone pratiche e per esercitare egemonia costituente dobbiamo sperimentare senza sosta nuovi linguaggi e nuove alleanze.







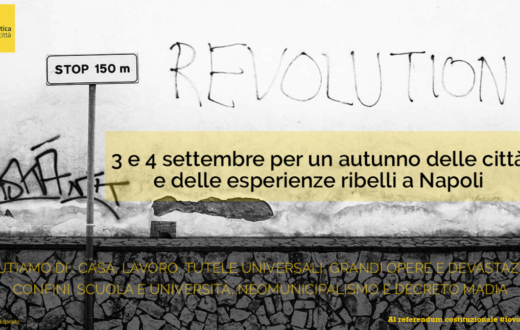
0 comments