Un racconto autobiografico di Taibo II sulla sua generazione dall’utopia rivoluzionaria a oggi
Loro (ossia noi 45 anni fa). Loro pensavano di essere immortali. Erano assolutamente convinti che il passato, il presente e il futuro fossero materiale intercambiabile anche solo in un ciclo di 24 ore. Era la conseguenza di non avere abbastanza passato, di avere un disinformato eccesso di involontario rispetto per il presente e di non essersi messi a pensare seriamente al futuro. Non avevano la capacità di immaginare pessimisticamente il futuro. E quindi nemmeno di intuire che esistesse quella cosa chiamata avvenire. Loro credevano fedelmente nella moltitudine di fantastici paradisi futuri che in quegli anni erano di moda, e naturalmente non condividevano la maligna frase di Paul Nizan che dipingeva l’adolescenza e la giovinezza come una disgrazia irreparabile; sebbene la citassero spesso, facendola passare per la penna di Malraux.
Loro parlavano di se stessi come fossero volatili, effimeri, come se fossero sempre sull’orlo della sparizione o della consacrazione. Sembravano logori eroi poco più che adolescenti, discepoli di un Houdini maoista dotato del senso dell’umorismo, o personaggi di un Rulfo leninista, urbanizzati da 50 anni di magia ripetitiva e autoritarismo statale priista (in riferimento al Pri, il partito al governo del Messico per 70 anni dal 1929 al 2000, ndt).
Loro intuivano che niente era totalmente impossibile.
Forse la colpa era del clima, dell’atmosfera irreale che si viveva nella Città del Messico degli anni Sessanta, delle perniciose piogge di quel settembre.
Erano giorni in cui le illusioni svanivano senza lasciare il retrogusto della sconfitta, perché erano state sostituite rapidamente da altre nuove illusioni altrettanto splendide, fiammanti e rotonde. Loro avevano una leggera ammirazione per i Puma, perché erano universitari e venivano dalla seconda divisione. Ammiravano pochi sportivi, solo gli impossibili e i pazzi come il ceco Emil Zátopek, la locomotiva umana, o l’etiope Abebe Bikila, magro e smunto, figlio di una dieta a base di fame, morto a 41 anni, due volte vincitore della maratona. E naturalmente anche Sir Edmund Hillary e lo sherpa Tensing, a cui il neozelandese disse che la ragione suprema per salire sull’Everest (8.848 metri calcolati sull’impossibile linea retta che nessuno usa) era because is there (“perché sta lì”), cosa che rimase senza risposta perché lo sherpa tenne per sé quello che stava pensando, e cioè che lui lo sapeva da molti anni.
Loro indossavano camicie bianche e azzurre di cotone grezzo e pantaloni di jeans lievemente scampanati, senza arrivare alle zampe di elefante; le ragazze usavano bluse rosa e azzurro pallido con ricami messicani, e pantaloni di jeans, perché la minigonna non era una buona compagna per entrare di sera e uscire di notte dai quartieri operai.
Loro, gli uni e le altre, accorrevano impavidi come tanti Peter Pan e Campanellino al timone della corazzata Potëmkin in una città sporca e aspra dove se ti distraevi ti potevano rompere le calze con un coltello, rubarti le illusioni, torturarti, ficcarti in una macchina blu e romperti la mandibola a calci, cavarti un occhio con la punta di un tondino, buttarti sotto le zampe di cavalli in corsa, dare scosse elettriche alle tue palle fino a farti sembrare un albero di Natale, riempirti i polmoni di gas e le costole di paletti, tirarti fuori le tue ultime paure e le tue ultime lacrime. Loro, gli uni e le altre, credevano di essere immortali e incorruttibili. Il tempo, che è una merda, si incaricò di dimostrargli il contrario, o una variazione: alcuni, solo alcuni, sarebbero stati corruttibili, ma tutti erano mortali.
Amore per il bene
Ormai è un luogo comune, questa cosa di dire che uno è attaccato a questa città da un cordone ombelicale, intrappolato in un misto di amore e odio. Ripasso le mie stesse parole. Mi sento l’ultimo dei moicani. Constato, confermo: non c’è odio. Solo un’enorme, un’infinita sensazione d’amore per la città mutante in cui abito e che mi abita, che sogno e mi sogna. Una volontà d’amore che più che risolversi nella rabbia, nel possesso o nel sesso, scivola nella tenerezza. Devono essere le manifestazioni, il colore dorato della luce nello Zócalo, le bancarelle dei libri, i tacos di carne, i fiumi di solidarietà profonda, gli amici dell’officina meccanica che mi salutano quando passo. Sarà questo meraviglioso sole d’inverno. Sarà.
Ogni storia è personale
Ho una forte relazione affettiva con l’Internazionale. È una delle canzoni che la mia famiglia canta alla cena di San Silvestro, ma non riusciamo a far funzionare il coro troppo bene. Mio padre la canta con il testo dei socialisti spagnoli degli anni ’30, come la cantava a dieci anni quando era in esilio in Belgio; è lo stesso testo che conosce mia moglie, Paloma, che lo imparò ascoltando suo padre e i suoi amici nell’esilio messicano. La mamma conosce la versione anarchica della Cnt che cantavano i suoi zii del sindacato dei muratori e le sue zie del sindacato delle sarte di Gijón. Io e mio fratello Benito conosciamo la traduzione messicana che cantavamo alla fine degli anni ’60, e mio fratello Carlos e mia figlia conoscono un miscuglio di tutto ciò. A cena, poi, magari c’è qualche amico italiano, e a volte qualcuno che l’ha imparata in Argentina.
Per cui il coro, oltre al fatto che siamo stonati di natura, viene stranissimo. Alcuni diranno “paria” della Terra, e altri “poveri”. Ma questa non è la chiave di tutta la faccenda? Un coro discordante di voci con accenti differenti e lingue diverse?
Ho pensato di scrivere in un foglietto che al mio funerale voglio far suonare una versione che credo di aver ascoltato, se la memoria non mi inganna, da Edith Piaf con l’orchestra e il coro dell’Armata Rossa. Poi ho rinunciato al proposito, non voglio lasciare ai miei sofferenti eredi l’impossibile compito di trovare quel disco. Non importa così tanto, quando sarà il momento di andarmene suonerà nella mia testa.
Loro. (Ossia noi 50 anni dopo)
Loro avevano reso pubblica l’intenzione di vivere cent’anni, e stavano reclutando in assemblee e conferenze, con un certo successo, volontari per fargli spingere in futuro le loro sedie a rotelle alle manifestazioni.
Loro si erano fatti delle magliette che sul davanti dicevano “Nati per perdere” e dietro “Ma non per negoziare”.
Loro avevano imparato che non esiste una cosa come “La vittoria finale”, bensì una successione di trionfi e fallimenti che obbligavano a concludere che la guerra contro lo Stato e i suoi demoni era perpetua.
Loro navigavano nell’eternamente ingiusta e abusiva società messicana come Robin Hood invecchiati, negandosi la pensione, pienamente coscienti che se Marx fosse nato a Toluca sarebbe morto fucilato al fianco di Rubén Jaramillo.
( Traduzione di Giovanni Dozzini)
***
Paco Ignacio Taibo II è tra le presenze più attese della terza edizione di Encuentro, il Festival delle letterature in lingua spagnola che si tiene a Perugia da domani all’ 8 maggio, e che quest’anno si apre anche alla musica, al teatro e all’audiovisivo. Tra gli altri scrittori presenti Enrique Vila- Matas, Luis Sepúlveda, Arturo Pérez- Reverte Info www. encuentroperugia. it
IL RITORNO
A quattro mani di Paco Ignacio Taibo II ( La Nuova Frontiera, trad. di C. Cacucci pagg. 448, euro 19) In libreria da dopodomani



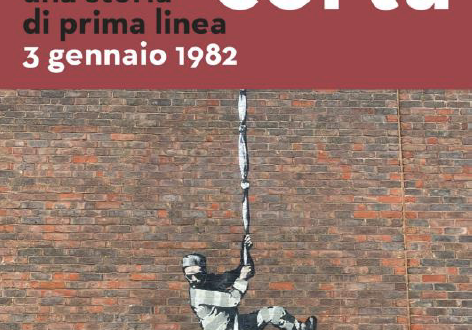




0 comments