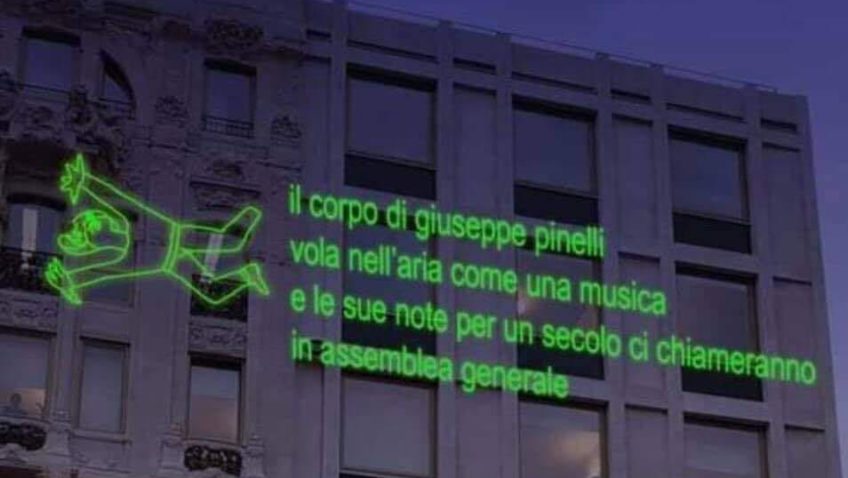Miceli, già tramite di un finanziamento di 800.000 dollari giunto al Msi dalla Amministrazione Usa nel ’72 e iscritto alla P2, verrà eletto nel ’76 deputato nelle fila del partito di Almirante. L’anniversario obbliga ad una lettura del presente, perché gli eredi missini che sono al vertice dello Stato rivendicano la loro storia come democratica e repubblicana
Il cinquantesimo anniversario della strage di Piazza della Loggia celebrato dal Presidente della Repubblica Mattarella spinge a volgere lo sguardo sul 1974, un anno cruciale dei tumultuosi Settanta, e pone l’obbligo della lettura del presente visto che, negli odierni tempi di acritica fedeltà atlantica, l’ultima inchiesta sull’eccidio fascista di Brescia ha condotto sulla soglia d’ingresso di Palazzo Carli a Verona, sede del comando Nato.
L’Italia era guidata dal quinto governo del democristiano Mariano Rumor, un esecutivo di breve durata ma obbligato a misurarsi sia con le temperie politiche nazionali e internazionali (crisi economica, guerra del Kippur, austerità) sia con lo stragismo neofascista che dal 1969 era deflagrato nella vita pubblica.
Dopo la strage di Brescia, per la prima volta dopo anni di omissioni; arresti politici; false piste anarchiche e depistaggi istituzionali, il governo fu costretto ad attivare le prime misure di contrasto (seppur calibrate, come in uso al metodo democristiano) contro l’eversione nera. Fu un primo segnale di discontinuità per un partito/Stato su cui gravava la responsabilità politica degli accadimenti. «Per quanto riguarda la strategia della tensione che per anni ha insanguinato l’Italia – scrive Aldo Moro nei giorni del suo sequestro – non possono non rilevarsi, accanto a responsabilità che si collocano fuori dall’Italia, indulgenze e connivenze di organi dello Stato e della Democrazia Cristiana in alcuni suoi settori».
Per avviare le «pulizie in casa» (rimuovere o trasferire vertici e alti ufficiali degli apparati di forza statali compromessi con l’eversione nera) l’esecutivo guidato da Rumor (che il 17 maggio 1973 aveva subito un attentato del gruppo nazista Ordine Nuovo) utilizzò due dei suoi più importanti maggiorenti nei dicasteri strategici: Giulio Andreotti alla Difesa, Paolo Emilio Taviani all’Interno.
Andreotti il 20 giugno, in una a dir poco inusuale intervista a Il Mondo, svelò l’identità di agente dei servizi segreti di Guido Giannettini – il «collaboratore fascista del SID» lo definirà Aldo Moro – indagato per la strage di Piazza Fontana e fatto fuggire all’estero. Poi lo stesso ministro non solo consegnò alla magistratura una parte della documentazione relativa al golpe Borghese del 1970, riattivando l’indagine, ma rimosse dal vertice del SID il generale Vito Miceli che il 31 ottobre fu arrestato, poi assolto, per le inchieste sul golpe Borghese e per quello della Rosa dei Venti.
Miceli, già tramite di un finanziamento di 800.000 dollari giunto al Msi dall’amministrazione Usa nel 1972 nonché iscritto negli elenchi della P2, verrà poi eletto deputato nelle fila del partito di Almirante nel 1976.
Taviani due giorni dopo la strage di Brescia sciolse l’Ufficio Affari Riservati, gravato delle più pesanti accuse di complicità con l’estrema destra, spostando il suo potente capo (nonché suo uomo di fiducia e riferimento della CIA in Italia) Federico Umberto D’Amato alla guida della Polizia di Frontiera. Lo stesso D’Amato che l’ultima sentenza per la strage di Bologna indica come uno degli organizzatori del massacro del 2 agosto 1980 eseguito dai neofascisti dei Nar. Uno scioglimento che seguiva quello del gruppo Ordine Nuovo del 23 novembre 1973 voluto dallo stesso Taviani (dopo la condanna dei suoi dirigenti per ricostituzione del partito fascista) e l’arresto l’8 maggio 1974 di Carlo Fumagalli, guida del gruppo eversivo MAR (Movimento Azione Rivoluzionaria) già ufficiale dell’OSS statunitense e poi della CIA, nonché membro della Resistenza «bianca» di cui proprio Taviani era stato al vertice durante la seconda guerra mondiale. Il 30 maggio il neofascista Giancarlo Esposti (legato al Mar) veniva ucciso in uno scontro a fuoco con i carabinieri a Pian del Rascino.
Si assisteva allora al riposizionamento della classe dirigente protesa a ricostituirsi -scrisse Pasolini- «una verginità antifascista, a tamponare il disastro del referendum» che aveva confermato la legge sul divorzio e posto per la prima volta la Dc (alleata al Msi) in minoranza nel Paese.
Si assiste oggi, in tempi in cui gli eredi missini sono al vertice dello Stato e rivendicano la loro storia come democratica e repubblicana, al tentativo di rimozione del contesto di quegli anni così ben rappresentato dal palco di Piazza Loggia dalle parole del sindacalista della Cisl Franco Castrezzari troncate dallo scoppio della bomba: «La nostra Costituzione vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista; eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordinava spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell’arco antifascista e perciò costituzionale».
* Fonte/autore: Davide Conti, il manifesto