Lo sa bene chi interviene in carcere, chi ne ha esperienza: il rischio del doppio binario, in superficie le “belle cose”, sottotraccia la violenza taciuta delle “X sezioni” è un rischio che va sciolto, affrontato. E uscire dal silenzio è la sola scelta possibile
«Celle dedicate alla punizione dei detenuti con scompensi psichici. Venivano obbligati a spogliarsi e a gridare frasi come “Sono un pezzo di m…” mentre gli agenti li malmenavano con schiaffi e pugni, attrezzati di guanti per non lasciare i segni. “Figlio di p…, ti devi impiccare” urlava la guardia carceraria Antonio Ventroni al detenuto Daniele Caruso dopo averlo portato in infermeria.
In due gli sputavano addosso e lo colpivano con violenti pugni al volto, provocandogli un ematoma a un occhio, emorragia dal naso e una lesione a un dente incisivo superiore che, dopo qualche tempo, a causa di quel colpo cadeva”. Decine di episodi a partire dalla primavera del 2017, denunciati prima dai detenuti e poi dalla garante di Torino, Monica Gallo, ma sempre ignorati a tutti i livelli.
È l’intero “sistema carcere” a essere finito sotto inchiesta da parte del pubblico ministero di Torino Francesco Pelosi: inchiesta che si è chiusa con 25 indagati che vanno dal direttore della casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, Domenico Minervini, al capo delle guardie carcerarie, Giovanni Battista Alberotanza, ai rappresentanti del sindacato più attivo della polizia penitenziaria, l’Osapp.
Violenze fisiche e vessazioni ai detenuti, denunciate in più occasioni, costano ai principali indagati l’accusa di tortura, per “condotte che comportavano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona detenuta”, reato mai contestato prima per le violenze all’interno del carcere. Favoreggiamento e omissione di denunce di reati sono invece le accuse per il direttore Domenico Minervini, il quale avrebbe sempre ignorato le lamentele e le segnalazioni della garante, lasciando che gli agenti agissero indisturbati.
Erano le celle numero 209, 210, 229, 230 della X Sezione quelle prescelte per isolare i detenuti che davano segno di scompenso psichico, nonostante nel carcere di Torino esista una sezione apposita per quel tipo di problematiche. L’ispettore Maurizio Gebbia e altri agenti penitenziari portavano lì i reclusi per “punirli” nel silenzio generale che consentiva loro di eludere le indagini.
E quando i detenuti erano troppo malconci e dovevano farsi visitare li minacciavano dicendo loro che “dovevano dichiarare che era stato un altro detenuto a picchiarlo, altrimenti avrebbero usato nuovamente violenza su di lui, così costringendolo il giorno successivo alle violenze a rendere in infermeria questa falsa versione dei fatti”, come è riepilogato nel documento di chiusura delle indagini».
Così le cronache dei giornali riferiscono della chiusura dell’inchiesta sulle violenze contro reclusi nel carcere di Torino (Ottavia Giustetti, “la Repubblica”, 21 luglio 2020).
Ora i giudici dovranno pronunciarsi ed eventualmente confermare le accuse emerse dalle indagini che ieri si sono chiuse e che meritoriamente si erano aperte grazie alle denunce degli stessi detenuti e alla Garante di Torino.
Quello che, intanto, si sa per certo è che detenuti e Garante hanno portato sul tavolo dei magistrati materiale sufficiente a non far archiviare il caso e un velo è stato squarciato. Quel velo che da molto tempo, ma negli anni più recenti con più aggressività, è stato tessuto anche mediaticamente a copertura di una realtà profonda del carcere, quella della sua perdurante natura violenta di istituzione totale e dell’impunità di chi quella violenza esercita, che nel buio delle notti delle tante “X sezioni” non ha mai smesso di produrre arbitrio, botte, umiliazioni. Torture.
Chi scrive sa – per personale esperienza, avendo vissuto a lungo nelle celle anche del carcere torinese, e per conoscenza, dai tanti anni di impegno, lavoro e attività sul carcere – che per una volta che si fa giustizia per altre cento, o mille, volte cala il silenzio. Il silenzio della paura, della debolezza, della mancata tutela di chi subisce; il silenzio dell’opacità dell’istituzione, del mancato o omesso controllo di chi agisce, della sottovalutazione o, peggio, della copertura. La cultura dell’omertà, in questi casi, non solo lascia condotte gravissime impunite e esseri umani indifesi, picchiati e nudi, in balìa della violenza, ma concorre a legittimare, in silenzio ma nei fatti, una violenza che diventa istituzionale, tollerata, ammessa, anche quando la maggioranza degli agenti non la condivida e non la pratichi, o magari pensi che un carcere “costituzionale” sia più gestibile, anche per loro, di un carcere violento.
Il silenzio la permette, la reitera, la consacra, questa violenza. Anche per questo, onore ai detenuti che hanno denunciato, rischiando come solo in carcere si rischia, e alla Garante che ha svolto il suo compito, rispettandone il mandato profondo.
Da anni, e nei tempi più recenti soprattutto, i media rilanciano, spesso senza approfondimenti e tanto meno contraddittorio, comunicati stampa e prese di posizione di alcuni tra i sindacati di polizia penitenziaria – incluso quello citato nell’articolo – la cui cifra è quella di rimandare alla pubblica opinione un’idea di carcere in mano ai detenuti, gestito in maniera lassista; i reiterati attacchi portati a chiunque voglia introdurre elementi di riforma e maggior rispetto della norma costituzionale, si ripetono, fino al più recente attacco frontale contro la figura e i compiti del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Figura di cui, ancora ieri, uno di quei sindacati ha chiesto l’abolizione.
Così, anche le lotte contro la disperazione indotta da una sciagurata gestione dei provvedimenti anti Covid-19, diventa l’immagine di un carcere dominato da pochi caporioni, immagine ridicola per chi di carcere ne sa, ma seducenti per chi non ne sa (e preferisce non sapere). Una comunicazione che ha presa su una società che del carcere tutto ignora, e che al contempo nutre una – ed è nutrita da una – crescente voglia di forca.
Una comunicazione mediatica schizofrenica, che a volte concede qualche piccolo spazio alle “belle cose” che si fanno in carcere, quando il mondo esterno, le associazioni, il volontariato, gli enti locali si danno da fare per costruire ponti tra dentro e fuori, per sostenere percorsi di ritorno alla libertà, per smussare l’isolamento e l’opacità della detenzione. “Belle cose”, progetti culturali e sociali, che anche noi, negli anni, anche a Torino, abbiamo fatto, promosso, sostenuto, nella convinzione che “liberarsi della necessità del carcere” sia un percorso, non possa essere uno slogan. Ma se le “belle cose” non sono – sempre, con forza, con consapevolezza – incardinate in una decisa azione di conoscenza, controllo, presidio dei diritti fondamentali di chi è rinchiuso, rischiano di tradire i loro stessi fini.
Lo sa bene chi interviene in carcere, chi ne ha esperienza: il rischio del doppio binario, in superficie le “belle cose”, sottotraccia la violenza taciuta delle “X sezioni” è un rischio che va sciolto, affrontato. E uscire dal silenzio è la sola scelta possibile.
Forse è anche per questo che il carcere di Torino ha deciso, proprio nel 2017, che a due persone come noi, nonostante la volontà di dialogo, la propositività, le pregresse esperienze e quelle in corso in altri carceri, fosse vietato di entrare e lavorare con i detenuti e le detenute. Dopo una martellante campagna mediatica, condotta soprattutto dal citato sindacato, accolta e rilanciata dai media locali senza chiedersi se ci fossero altri punti di vista, e persino dall’allora procuratore capo, dopo il veto della polizia penitenziaria dell’istituto, che evidentemente conta più di ogni altro potere, siamo stati espulsi. Non un gesto, non una scorrettezza che ci potesse essere imputata, solo il dato biografico di essere stati a lungo detenuti in quelle celle, di portarne una diretta conoscenza, e di pensare, con molti e molte altri, che i diritti di chi è recluso siano una frontiera che nessuno può oltrepassare.
Ciò che oggi ci colpisce, ricordando quei giorni e quei fatti, è che era lo stesso anno, erano gli stessi mesi in cui cominciavano ad accadere le violenze e le torture oggi sul tavolo della magistratura. Gli ultimi nostri ingressi, lo spettacolo teatrale con le donne detenute e un incontro con i detenuti nel teatro del carcere, dedicato al tema dell’ergastolo ostativo, con la proiezione del docufilm “Spes contra Spem”, di Nessuno Tocchi Caino, anch’esso spesso, e di nuovo ieri, attaccato da quei sindacati.
In questa registrazione dell’evento di Radio Radicale c’è qualcosa che va riascoltato: le prime parole sul quel maledetto 2017, allora trascurate e silenziate ma oggi illuminanti. Ascoltatele con attenzione, dal 45,47° minuto e poi dal 54° del file 2/2 di quel video




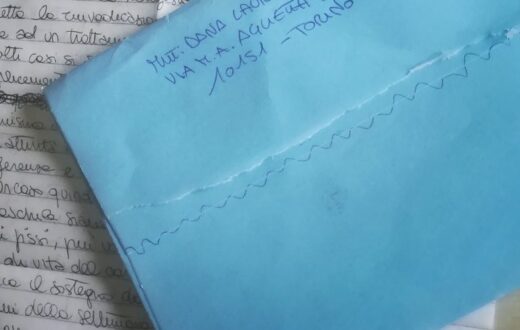



0 comments