Giornalista, artista, utopista, irrequieto e trascinatore. È morto a 87 anni il grande reporter Mario Dondero che diceva: “Il vero compito della fotografia è farci capire l’uomo”
Solo a Mario Dondero, nella sua malattia terminale, poteva accadere di chiedere davanti alla meraviglia di medici e infermieri di farsi un ultimo pasto in trattoria. E così accadde. Per ben tre volte. Mi dicono che mangiò di gusto e accennò Les Feuilles Mortes — uno dei suoi cavalli di battaglia — una canzone che gli somigliava, prima di farsi riportare nel luogo della sua ultima degenza. È morto ieri, a 87 anni, a Fermo dove mercoledì ci saranno i funerali. Davvero, Mario fu speciale. Ci si era fuggevolmente incontrati in occasione della sua grande mostra a Roma. L’ultimo omaggio a una storia per certi versi straordinaria. Vissuta con leggerezza e passione. Era lì, nel bellissimo spazio delle Terme di Diocleziano, affaticato ma felice. In mezzo alla gente. Vecchi amici e tanti giovani. Sbalorditi dal lavoro che nel corso di una vita aveva saputo svolgere e raccogliere come fosse un grande romanzo sul mondo. Consapevole che la storia la fanno gli altri e riluttante a celebrarsi. Forse in omaggio al frutto anarchico che ha assaporato come la sola forma di libertà autentica. E quella sera, tra le centinaia di foto, mi sembrava contento di essere ancora una volta nel posto giusto al momento giusto. Anche se quella coincidenza, tra il luogo e il momento, sembrava non lo riguardasse personalmente. In fondo poche persone come Mario Dondero si sono disinteressate al proprio destino. Alla propria storia. Una trascuratezza che è stata insieme modestia e rispetto dell’altro. Artigianato, grandissimo, e storia sociale.
Aveva attraversato esperienze aspre e precoci. A 16 anni era stato in montagna con i partigiani. Catturato dai fascisti si salvò miracolosamente. La guerra portava con sé i pericoli e le tragedie. Poi vennero gli anni della speranza. L’idea di entrare in una nuova vita. Aveva una passione naturale per il giornalismo. Mario era nato a Genova. Avrebbe dovuto fare il marittimo seguendo le tradizioni familiari. I suoi cugini erano marinai. Si iscrisse al nautico di Camogli e poi invece si ammalò e gli fu consigliato il ginnasio.
Nei primi anni Cinquanta si stabilì a Milano. C’erano i quattro punti cardinali: la Scala, il Piccolo, l’Accademia di Brera e il Giamaica.
Dondero cominciò a frequentare quest’ultimo. Era un bar e un ritrovo di gente che avrebbe fatto un po’ di storia culturale. Vi conobbe Alfa Castaldi che sarebbe diventato un eccellente fotografo di moda. Si riconobbero dal fazzoletto rosso di partigiano. Al Giamaica si incontravano artisti come Gianfranco Ferroni e Piero Manzoni. Fotografi alle prime armi come Ugo Mulas e perfino il fratello di Antonio Gramsci che giocava a scopa con il Maestro Confalonieri. Bianciardi ha illustrato con La vita agra che cosa sia stata quella stagione, che per Dondero cominciò nel 1952 e finì due anni dopo. A Parigi arrivò alla fine del 1954. Ho ancora sotto gli occhi la sua fotografia più celebre. La più letteraria. Un gruppo di premi Nobel, tra cui spiccava serafico Samuel Beckett, davanti all’entrata delle edizioni Minuit. Fu Mario che in un momento ebbe l’idea di raccogliere quel parterre di scrittori che quasi senza saperlo davano inizio a una stagione segnata dal Nouveau roman. Tre cose prese dalla Francia: la Rivoluzione (quella dell’89 e in parte il ‘68); le donne e qualche fotografo. Tra questi Willy Ronis — un ebreo di Odessa, emigrato in Francia — il cui sguardo stregò Dondero. Conservava ricordi bellissimi di Henry Alleg, un fotoreporter arrestato e torturato durante la guerra di Algeria dall’Oas. Furono anni straordinari cuciti dall’esistenzialismo e dagli scrittori che Dondero frequentava: Arthur Adamov, Claude Simon e dagli attori — spesso emigré — come Serge Reggiani e Yves Montand.
Il talento non lo ha reso ricco. Si aveva la sensazione che la sua carriera sarebbe potuta essere molto più confortevole e omaggiata. Detestava lavorare a lungo e stabilmente per una testata. Temeva che avrebbe finito con l’appiattire il suo stile, spersonalizzarlo: «Un fotografo », disse, «non può che essere un freelance o, meglio, un cane sciolto». Si definiva di sinistra. Gli piaceva, istintivamente, stare dalla parte dei deboli. E non aveva rinunciato all’idea che si potesse, chissà, forse un giorno, costruire un mondo nuovo. Senza eccessi ideologici né utopie. C’era in lui qualcosa che sfiorava la religiosità. Un senso di laicissima propensione verso il mondo che egli chiamava pietas. Era l’amore per la gente. O meglio per le classi umili.
Senza essere credente proiettava la tensione verso l’altro, non a caso gli era capitato di intraprendere faticosi viaggi con gli amici di Emergency in Afghanistan. Si muoveva sempre con uno spirito contro, contro lo strapotere contro ciò che opprime. E si è sempre considerato un fotografo politico. Dondero è stato uno dei grandi fotoreporter degli ultimi cinquant’anni. Aveva una regola: non servirsi degli uomini per fare fotografia, ma fare fotografia per capire meglio gli uomi- ni.
Nel suo lavoro di reporter ha cercato di essere il più semplice e lineare possibile. Raccontando la realtà in modo aderente al vero. Era il valore che egli dava alla verità del momento. Mentre provava fastidio per l’abbellimento, l’estetica, l’artificioso. Sapeva che esistono molti modi di fare fotografia. Ma chi vuole raccontare la realtà, non la inventa. La osserva e la interpreta. Anche, e forse soprattutto, con il pathos che ogni gesto umano a volte nasconde. Consapevole che l’arroganza, il sopruso, la violenza sono tratti altrettanto ineliminabili. E non a caso le foto che egli ha realizzato nella Fortezza di Terezin, in quel teatro di una crudeltà senza appello dove gli ebrei venivano rinchiusi e torturati, stanno lì a mostrarci la potenza devastante del nostro passato. Le porte spalancate delle celle, gli spazi minuscoli e temibili, occupati degli interrogatori della Gestapo, gli esterni di quella minacciosa costruzione dicono, quando anche il dire stenta a farsi parola, a rendersi comunicazione.
Che ne è della immagine, se l’immagine testimonia l’invedibile? Fu l’interrogativo dei suoi ultimi tempi. Senza possibile soluzione che non fosse quella dettata da una coerenza e da una dignità di mestiere.
L’ho rivisto, un’ultima volta, all’ospedale di Fermo. Dormiva. «Dopo giorni di sofferenza finalmente ha un’aria serena», mi ha detto Laura, la straordinaria compagna degli ultimi anni. La stanza piccola e luminosa. Il respiro leggero. Poi si è svegliato. Il volto scavato, calmo e gentile. La gentilezza, mista alla generosità, lo hanno fatto molto amare. Dai figli. Dagli amici. Dalle donne. Dalla vita.
Born to Walk. Strano. Se penso oggi a lui vedo l’uomo uscito di scena, la cui testimonianza resta tra noi. Ci precede e ci ricorda un signore con una vecchia macchina fotografica e uno sguardo che sembra uscito da una canzone di Yves Montand. Mario è stato un intrattenitore formidabile: «Oh vorrei tanto che tu ricordassi i giorni felici quando eravamo amici».
Fu un narratore di storie costruite con la lingua degli istanti. Lo vedo ancora mentre si offre ai rischi dell’esperienza sapendo che ogni cosa accade perché è così che deve essere.





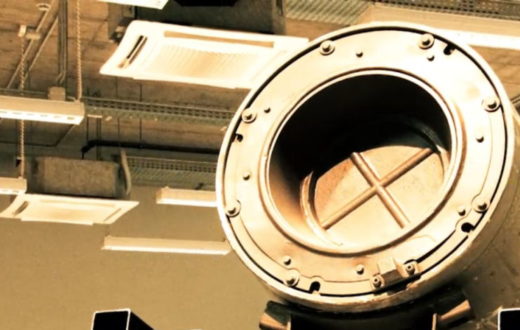


0 comments