L’Introduzione del libro ” Prendiamoci la città – Una storia così non dovrebbe finire mai” – edizioni La Barricata
Prima del ’68
Nel ’46, di fronte alla gravissima carenza di abitazioni nelle città italiane (largamente distrutte dai bombardamenti aerei) e alla minaccia di forti aumenti degli affitti, si costituisce un Comitato case-alloggi, cui aderiscono tutti i partiti del CLN. Accanto a questo comitato ufficiale si formano spontaneamente squadre di partigiani e di reduci (i più duramente colpiti dalla guerra). Insieme rastrellano le vie della città per segnalare le case sinistrate, gli alloggi liberi e recuperabili, e chiedono stanziamenti per la ricostruzione. Decisamente inaspettato, e segno dei tempi, degli umori e dei rapporti di forza, è l’invito che le organizzazioni sindacali rivolgono ai propri aderenti a non pagare l’affitto di fronte agli aumenti voluti dai padroni di casa. Benché tale pratica non sarebbe stata poi portata avanti a fondo, questa sarà l’unica volta in cui il sindacato lancia una parola d’ordine come quella dello sciopero dell’affitto, che avrebbe in seguito considerato un’arma inutile e pericolosa. La situazione in generale è assai critica: di fronte ai 300 mila senza casa, 40 mila alloggi risultano vuoti e ben 16 mila dei nuovi costruiti in quegli anni non vengono destinati ad abitazioni. Ad aggravare il tutto è lo sblocco degli affitti che scatta nel ’51: centinaia di lettere-capestro vengono inviate agli inquilini, mentre gli sfratti si susseguono al ritmo di otto famiglie al giorno. La risposta allo sblocco è debole: l’Associazione degli inquilini e dei senzatetto invita i propri aderenti a opporsi agli sfratti, ma non imposta una linea unitaria e vigorosa 1. Negli anni ’60 il fronte della casa è ancora “caldo”: gli edifici sia pubblici che privati di nuova costruzione sono del tutto insufficienti a coprire il fabbisogno dei ceti meno abbienti, mentre gli affitti raggiungono quote altissime e gli sfratti sono agevolati dalla “giusta causa”. La fase di boom economico, con i connessi fenomeni di crescente immigrazione e pendolarismo, aggrava i problemi abitativi del milione e mezzo di abitanti di Milano. Ci sono alcuni casi di protesta, che vedono scendere in piazza gli immigrati, in genere edili, che abitano nelle baracche messe a disposizione dai costruttori o gli operai alloggiati nelle case-lager della Siemens. Si tratta però di casi isolati. In tutti questi anni, benché si assista a una ripresa di lotta sul fronte operaio, che conosce anche momenti di scontro duro, il movimento per la casa non esce da una logica corporativa e legalista, sostanzialmente moderata. Bisognerà attendere il ’68 perché si sviluppi un’azione forte, rinnovata negli obiettivi e nelle forme di lotta, finalmente all’altezza dei problemi.
Dopo il ’68
Si formano nuclei di lotta decisamente più risoluti che portano l’azione su un piano di scontro reale, determinato dai rapporti di forza tra le classi invece che dalle mediazioni di vertice e dall’ideologia legalitaria. È da queste lotte che prende il via il nostro lavoro di ricostruzione del periodo immediatamente successivo, quello che va dal ’70 al ’72. In questo lavoro non vogliamo tanto analizzare il fenomeno delle occupazioni e le varie linee politiche che le sostenevano, quanto sottolineare la portata di una parola d’ordine come fu quella di “Prendiamoci la città”. I soggetti di questo progetto, appoggiato dal movimento in generale, sono alcuni militanti di Lotta Continua e di Sinistra Proletaria, il Collettivo Autonomo di Architettura, gli occupanti e le donne, queste ultime sempre trainanti durante le occupazioni (a Palazzo Marino su 53 arrestati, 46 sono donne). L’“autunno caldo” del ’69 a Milano vede un passaggio di trasformazione in cui nel movimento si valuta che la lotta in fabbrica non costituisca più il punto avanzato dello scontro politico, ragion per cui è necessario sostenere e promuovere il conflitto sul territorio. È da qui che nasce la strategia riassunta nella parola d’ordine “Prendiamoci la città”. Proviamo a spiegare cosa voleva dire. La fabbrica capitalista funziona finché gli operai rimangono estranei l’uno all’altro. La base di questo sistema è il lavoro salariato, cioè la trasformazione degli uomini in merci messe al lavoro. Gli operai sono costretti a vendere al padrone le proprie energie e la propria intelligenza. Non appena essi cessano di lasciarsi trattare come merci e prendono coscienza della propria forza, la produzione si inceppa e nella fabbrica si crea il caos. Non si tratta più di governare singole macchine da lavoro tra loro separate ma di governare le acque di un fiume in piena che sviluppa bisogni e desideri propri e, a partire da ciò, si rende conto della forza che ogni sua goccia può esprimere sul posto di lavoro.
Dalla fabbrica alla società
Se in fabbrica si imparava a lottare insieme, una volta fuori gli operai tornavano spesso a essere soli o con le proprie famiglie, comunque costretti ad arrangiarsi in un territorio ostile. Relegati entro i confini fisici e mentali dei quartieri-ghetto, nelle periferie, stipati in edifici simili ad alveari, senz’aria né verde; oppure, se da poco immigrati, ammucchiati come sardine nelle case più vecchie, in soffitte, scantinati, pensioni e stabili fatiscenti. Non mancano i lager, con tanto di recinto, baracche e guardiani, quali sono i “centri sfrattati”. I nuovi quartieri sono costruiti in modo che nessuno si incontri, come avviene nei condomìni, dove i vicini di casa non si conoscono tra loro e a malapena si salutano. L’architettura e l’urbanistica, al servizio del capitale, ridisegnano una città in cui si vive ammassati, magari condividendo la stessa stanza e la stessa miseria, ma sovrastati dal sentimento di non avere niente in comune. Solo spostando la lotta dalla fabbrica alla città, portando fuori la forza della coscienza di classe che si era accumulata tra i muri delle fabbriche, facendola tracimare nelle strade, nei quartieri, per rompere quella solitudine di massa cui l’operaio tornava dopo il lavoro, solo così si sarebbero potute determinare le condizioni affinché i proletari riuscissero a immaginare e praticare altri modi di vita. È da richiamare, prima di concludere, il contesto affatto particolare della situazione politica internazionale dei primi anni ’70, dove quasi ovunque si confrontavano spinte rivoluzionarie e spinte controrivoluzionarie, che investe l’Italia, un Paese già visto come laboratorio anticomunista. Fu dalla reazione degli operai e di tanta gente comune di Milano alla strage di Piazza Fontana che apparve come inevitabile una radicalizzazione dello scontro nella direzione di una probabile guerra civile. Strutture armate legate a ipotesi golpiste di segno atlantista coinvolsero allora una parte dello Stato, mentre è presumibile che anche a sinistra fosse stato operato l’armamento delle avanguardie rivoluzionarie. Dalle lotte nascevano l’idea di un contropotere e il sogno di una rivoluzione in un Paese che era al contempo “polo avanzato” e “anello debole”. Su questo piano è necessario che il lettore operi un certo sforzo d’immaginazione, tanto possono apparire oggi lontani umori e percezioni che ai tempi riempivano le vite quotidiane e l’immaginario di un’ampia parte della popolazione.“Prendiamoci la città” significava tutto questo. Non si trattava di fare la rivoluzione ma di costruirne un passaggio fondamentale, la saldatura tra fabbrica e territorio, in una prospettiva di lotta di lunga durata. Questo nostro lavoro di ricerca e documentazione, di cui teniamo a sottolineare il carattere anonimo e compartecipato – “La Barricata” può essere chiunque -, non vuole dare alcuna indicazione politica a chi oggi lotta sulla questione dell’abitare e dei “territori resistenti”. Nondimeno, siamo convinti che queste testimonianze di un passato irripetibile possano contribuire a riflettere sullo stato presente delle cose e sui possibili significati, quarant’anni dopo, del “prendersi la città”.Attraverso le interviste, i testi teorici, le foto di quegli anni si delinea un percorso in cui si passa da forme di “arrangiarsi” individuali all’azione politica collettiva. Lì si producono nuove forme di vita all’insegna dell’auto- (autorganizzazione, autonomia, autogestione); lì nascono basi/retrovie di resistenza e liberazione; lì l’autodifesa nella precarietà si trasforma in una forza che, fuoriuscendo dagli spazi che la città riserva alla marginalità, esige quanto serve, subito, e se lo prende. Registrare questo percorso, breve ma intenso, significa sottolineare una sua forza intrinseca che si sottrae all’usura del tempo.
Fonte: Prendiamoci la città
guarda il film “La città del capitale – Il conflitto sociale urbano: il caso di Milano” del Collettivo Cinema Militante sulla lotta per il diritto alla casa negli anni ‘70





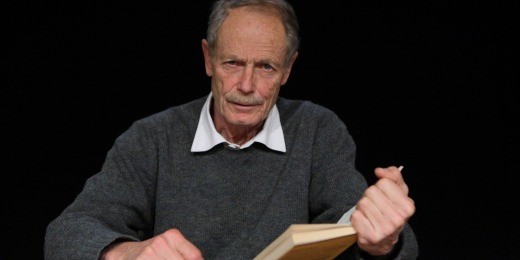


0 comments