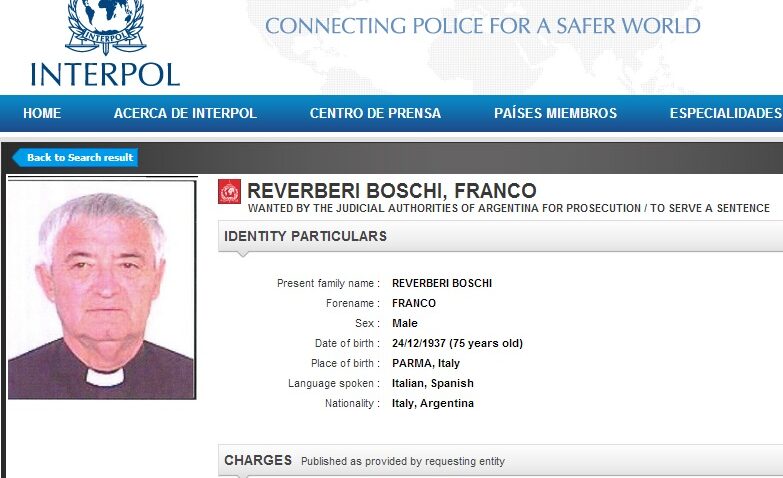I volantini durante Italia-Germania nel ’78, l’inseguimento di Wojtyla… se ne va un pezzo di lotta ai generali argentini
Prima di morire, aveva chiesto di venire salutata con un bel tango, lei che in vita, a dispetto di tutto, non aveva mai perso il sorriso. Angela Boitano, da tutti conosciuta come “Lita”, se ne è andata ieri a 92 anni, dopo un lunga malattia, a pochi giorni di distanza dalla scomparsa di un’altra grande lottatrice per i diritti umani, Nora Cortiñas.
Presidente dell’Associazione Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita era fra le più note madri di origine italiana impegnate nella ricerca dei figli scomparsi, insieme a Estela Carlotto e a Vera Jarach.
E in Italia, dove è vissuta per diversi anni in esilio, e dove ha testimoniato sia al primo che al secondo dei processi sui desaparecidos italiani in Argentina, sono in tanti a ricordarla con affetto: «È stata la madre di tutti noi esuli a Roma», ha commentato per esempio Claudio Tognonato. Nel 2001, il presidente Ciampi l’aveva pure nominata Commendatore al merito della Repubblica.
Nata a Buenos Aires nel 1931 da un’emigrante veneta arrivata in Argentina già incinta di lei, Lita, fin da giovanissima simpatizzante del peronismo, si era sposata a 20 anni con Miguel Boitano, rimanendo vedova nel 1960, a soli 37 anni.
Nel 1952 aveva dato alla luce la sua prima figlia, Adriana, e quattro anni più tardi Miguel. La dittatura militare gliel’ha strappati via entrambi: Miguel il 29 maggio del 1976 e Adriana il 24 aprile del 1977, sotto i suoi stessi occhi, mentre andavano a messa. «Mamma, l’unica cosa di cui ho paura è il dolore», le aveva detto lungo la strada.
Per ritrovarli aveva fatto di tutto. Si era pure spinta, durante la partita tra Germania e Italia ai mondiali di calcio del 1978, a distribuire volantini contro i crimini della dittatura. E l’anno successivo aveva anche rincorso Giovanni Paolo II a Puebla, in Messico, sperando – invano – di essere ricevuta.
LA REDAZIONE CONSIGLIA:
Argentina, dure condanne ai massacratori dell’Esma
Era allora venuta a Roma con altre madri e in piazza San Pietro lo aveva avvicinato: «Sono madre di desaparecidos. Le dobbiamo parlare. Deve riceverci». «Già, parli con il mio segretario», era stata la risposta del papa. Neanche allora erano state ricevute. Erano stati necessari un digiuno, una serie di testimonianze in parrocchie della periferia romana e una lettera consegnata all’allora segretario di Stato Casaroli da un parroco suo amico per far sì che, nell’ottobre del ’79, il papa parlasse dei desaparecidos. «Ne parlò come se fossero morti, dicendo che era molto vicino al nostro dolore. Mentre noi continuavamo a cercarli sperando di trovarli vivi», avrebbe commentato in seguito.
Non si era mai rassegnata. Testimoniando nel 2007 al processo sui desaparecidos italiani all’Esma (relativo ai casi «semplicemente simbolici» di Angela Maria Aieta e Giovanni e Susana Pegoraro), aveva dichiarato: «Quando hanno trovato i resti di Marcelo Gelman, li hanno portati al cimitero in una urna piccola. Io ero seduta lì vicino e ho visto che la madre l’abbracciava… senza piangere, senza gridare, senza niente, e io ho sentito in quel momento che… che anche io volevo ritrovarli, che sarebbe stato come averli un po’ con me».
LA REDAZIONE CONSIGLIA:
Una generazione da sterminare senza pietà
Qualche anno prima, del resto, aveva raccontato con emozione del conforto provato persino da quella sorta di inumazione burocratica resa possibile con l’introduzione, nel 1994, della figura giuridica dell’«ausencia por desaparición forzada», esplicito riconoscimento dell’esistenza del terrorismo di Stato: «Seguendo l’iter di quella pratica, richiedendo per esempio il certificato di nascita dei miei figli, mi ricordavo di quando lo facevo per la loro iscrizione a scuola. È una cosa che mi ha dato allegria».
* Fonte/autore: Claudia Fanti, il manifesto
ph Espacio Memoria y Derechos Humanos, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons