Collettivi politici, centri sociali, sindacalismo di base, sono oggi al centro di un vortice repressivo senza precedenti, e lo sono in base alla propria debolezza, non alla loro forza
Non è semplice, oggi, spiegare cosa comporti l’assunzione di un impegno politico militante in una fase di restringimento delle possibilità di partecipazione, di chiusura degli spazi reali di democrazia e di integrazione. In questo senso, la lotta contro l’Alta Velocità in val di Susa ha assunto il ruolo di laboratorio di sperimentazione non solo di precise tecniche repressive sul territorio, di fatto militarizzato oltre ogni fisiologica necessità da parte dello Stato, ma anche di un cambiamento di paradigma da parte dell’attività inquirente della magistratura locale.
Tale attività repressiva si è esplicitata, da una parte, in forme preventive di disincentivazione dell’attività politica, come ad esempio la moltiplicazione delle perquisizioni, anche violente, attuate sia nei posti di blocco che nelle case dei militanti, con sequestri discrezionali degli oggetti privati quali portafogli, computer, chiavette usb, vestiti, eccetera; dall’altro, dall’aumento sproporzionato della richiesta di misure cautelari, individuate come vero e proprio strumento sostitutivo delle pene detentive quasi mai, in sede di sentenza, passibili di applicazione. Sotto questo profilo, cioè rispetto alle tecniche utilizzate dalla magistratura al fine di reprimere l’attività politica dei militanti, particolare attenzione in questi anni è stata data al pagamento di multe, ammende e soprattutto dei risarcimenti pecuniari a seguito di particolari mobilitazioni politiche. Risarcimenti che, sempre riguardo al caso della val Susa, vengono sommati alla richiesta del provvisionale, cioè del pagamento immediato della somma richiesta prima ancora del termine del normale iter giudiziario. Colpire il portafoglio sembra essere una delle direzioni chiave del nuovo corso repressivo, volto a bypassare il normale percorso dei tre gradi di giudizio per provare a punire comunque il militante.
Tale paradigma da qualche tempo cerca di riprodursi anche a Roma, in particolare concentrandosi sulla lotta sociale principale della città, quella per la casa. Non solo i militanti più in vista inoltre, ma tutti i partecipanti a tale lotta vengono sottoposti a un giro di vite inquirente mai avvenuto da queste parti, dove la consapevolezza di tale emergenza sociale portava a tentativi di mediazione politica oggi completamente saltati. La lotta per la casa, e più in generale ogni lotta sociale cittadina, viene trattata unicamente come problema di ordine pubblico e di sicurezza, e così punita.
Questione che si esplicita nel cambiamento di gestione della piazza, visto ad esempio nel ridimensionamento del ruolo della Digos nello stabilire trattative contingenti con i manifestanti, all’utilizzo di provvedimenti repressivi in genere richiesti e attuati per reati d’altra natura. In sostanza, quello a cui punta la magistratura romana e una parte della politica cittadina è quello di de-politicizzare il carattere di tali proteste relegandole all’ambito della delinquenza comune. Paradigmatiche, in tale senso, le richieste della magistratura romana cinque anni dopo gli eventi di piazza del Popolo del 14 dicembre 2010, richieste sproporzionate e non legate ad alcun evento specifico, nella giornata in cui nel Parlamento si consumava quella che, a detta di tutti i media liberali, costituiva una delle pagine peggiori della storia repubblicana.
Questa la cornice entro cui si dovrebbe esplicitare un’attività politica non convenzionale, cioè legata a pratiche di autogestione collettiva.
Collettivi politici, centri sociali, sindacalismo di base, sono oggi al centro di un vortice repressivo senza precedenti, e lo sono in base alla propria debolezza, non alla loro forza. Un ragionamento, questo, che meriterebbe più riflessione se non si vogliono dilapidare esperienze che hanno contribuito alla tenuta democratica di questa città e di questo paese.





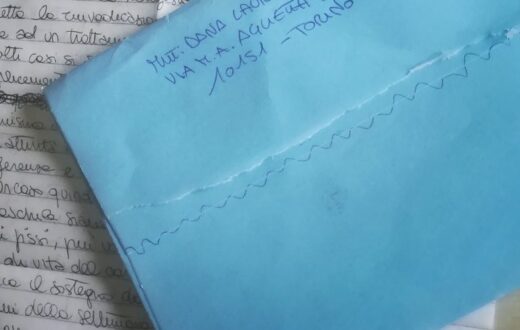
0 comments