Quello che la lotta e la rivoluzione potessero e dovessero tendere alla felicità, e anzi attualizzarla, è un pensiero che aveva corso anche allora, a partire dal Movimento del ’77, che lo teorizzò e tentò di praticarlo
Sergio Segio è stato, nel 1974, tra i fondatori di Prima Linea, con le Brigate Rosse la sigla che più insanguinò le cronache degli anni Settanta e Ottanta. Arrestato nel 1983, ha scontato 22 anni di carcere e oggi è impegnato come responsabile della “SocietàINformazione” e del Gruppo Abele di Milano. Nel libro Una vita in Prima Linea racconta i suoi anni di passione. Registrandone il sapore amaro delle illusioni e della sconfitta. Lo abbiamo intervistato.
Cos’ha provato scrivendo questo libro? Questa non è una biografia «normale».
Ho provato allo stesso tempo, e contraddittoriamente, inquietudine e serenità. Ripercorrere quegli anni e la mia esperienza dentro di essi è stato un percorso faticoso e doloroso. Le morti provocate, i tanti compagni rimasti uccisi, i lunghi anni del carcere, le torture subite, la sofferta presa di coscienza di quanto le aspirazioni originarie di maggiore giustizia e libertà si fossero rovesciate nel loro contrario, incidono in profondità la mia memoria e tutta la mia vita, e non è indolore riportarle alla superficie. Ma ripercorrerle a distanza di così tanto tempo e scriverne è stato, al tempo stesso, un percorso di riconciliazione con i tanti pezzi della mia esistenza. Credo non si possa e non si debba, né a livello individuale né a livello sociale, separare il passato dal presente. Per quanto costi fatica e comporti dei prezzi da pagare, occorre tenerli assieme, con la consapevolezza delle cesure ma senza comode rimozioni.
Mi ha colpito, dopo la sua liberazione, il viaggio a Mauthausen e poi a Goli Otok, luoghi della vergogna umana. Anche lei veniva da un abisso, era stato protagonista di una tragedia collettiva. Perché questa tragedia? Era proprio inevitabile?
Nulla è inevitabile, perché la storia la determinano gli uomini, con le loro volontà e anche con le loro cecità.
Naturalmente, le volontà dei singoli sono anche, e spesso fortemente, determinate da fattori più generali, culturali, sociali. Per quanto ci riguarda, sono convinto che le nostre scelte, la nostra tragedia – certo infinitesimale rispetto a quelle del Novecento, e nel giudizio occorre tenere sempre un senso delle proporzioni – siano state un intreccio indistricabile di intenzionalità soggettive, e dunque di responsabilità individuali, e di particolari contesti storici, culturali e politici: assolutizzare uno solo di questi fattori equivale a negare una faccia della verità. È necessario tenerli tutti presenti per capire davvero.
Dopo avere citato una pagina di Uomini e no lei dice che «la rivoluzione e il comunismo erano per lei nient’altro che questo: la possibilità di essere felici e liberi, sapendo che non lo si è veramente se non lo sono tutti». Ma si può costruire la felicità propria e quella degli altri con la violenza? È, questo sulla felicità, un suo pensiero di adesso, o la pensava così anche allora?
Quello che la lotta e la rivoluzione potessero e dovessero tendere alla felicità, e anzi attualizzarla, è un pensiero che aveva corso anche allora, a partire dal Movimento del ’77, che lo teorizzò e tentò di praticarlo.
In aperto contrasto con la logica del comunismo tradizionale e anche delle Br, che rimandavano al «sol dell’avvenire», a un lontano futuro e ai posteri, la questione di vivere il comunismo, e non solo di lottare per costruirlo. E in conflitto con il Pci e la Cgil di Lama, che in quel tempo avanzavano la linea della politica dei sacrifici, quel movimento, provocatoriamente, parlava invece di diritto al lusso. Anche il femminismo fu, da questo punto di vista, una rivoluzione culturale, che non accettava di subordinare a una futura e lontana società il radicale mutamento delle relazioni personali e di genere. Allora pensavamo alle armi come strumento e possibilità di liberazione, dunque di felicità. Abbiamo imparato, anche a nostre spese, che violenza e felicità sono invece antitetici.
Quanto influì, nella sua scelta di darsi alla lotta armata, la politica berlingueriana del compromesso storico?
Sarebbe intellettualmente disonesto dire che fu determinante, ma ebbe certamente un grosso peso. Perché si tradusse in una chiusura di spazi, in una stretta autoritaria rispetto ai movimenti, in una negazione di ogni dissenso. Paradossalmente, Berlinguer, all’indomani del golpe in Cile, motivava la proposta del compromesso storico con la Dc anche con le «minacce sempre incombenti» di svolte autoritarie. Svolte che in quegli anni venivano auspicate e talvolta organizzate anche da settori della stessa Dc e da apparati di quello Stato e di quelle istituzioni entro le quali il Pci si proponeva di compiere una «lunga marcia». Una scelta che ci appariva suicida, perché lasciava inerme la classe operaia e i ceti popolari. Basti ricordare che l’anno dopo, nel 1974, ci fu una intensificazione della strategia della tensione e dei tentativi di golpe, con la strage dell’Italicus e con quella di piazza della Loggia.
Quanto c’era, nella lotta armata, di continuità col mito partigiano, della Resistenza tradita? O non vi contò più, mentre imperversava la strategia della tensione, la volontà di reagire alla violenza della destra nell’ipotesi di sollevare le masse operaie?
Anche per noi, seppure in misura minore che non per le Br, vi fu, quantomeno nella fase iniziale, un richiamo forte, forse più sentimentale che politico, alla Resistenza, vista quale rivoluzione interrotta. Non è casuale che molti di noi avessero scelto come nome di battaglia quello stesso dei nostri padri partigiani. A questo filo si intrecciava poi il timore del golpe, l’esigenza dell’autodifesa rispetto ai fascisti e l’organizzazione di strutture che potessero fronteggiarli; assieme, ma non ultimo, vi era il mito della palingenesi sociale, del comunismo da costruire anche attraverso la lotta armata, come ci insegnavano le guerriglie dell’America Latina o, prima, la Rivoluzione d’Ottobre. La proporzione in cui si sommavano questi tre diversi elementi variava da organizzazione a organizzazione e anche da fase a fase.
È un dato ormai acquisito che la lotta armata non fu eterodiretta. Ma quanto la convince la tesi della Rossanda dell’album di famiglia?
Quella tesi della Rossanda dovrebbe apparire banale, eppure fu allora dirompente, tanto forte era il tentativo del Pci di mistificare la natura di sinistra delle organizzazioni armate. Anche per nascondere il fatto che le Br erano nate nelle sezioni del partito a Reggio Emilia. Mutatis mutandis, da quella sinistra allora eravamo spesso etichettati come oscuri provocatori, oggi veniamo considerati volgari criminali. L’intento e il risultato è il medesimo: quello di negare la nostra identità, che era quella di militanti della sinistra, e la natura politica della nostra vicenda.
A proposito del Pci lei parla, sin dagli anni Sessanta, di limiti e miserie del riformismo, di attitudine al compromesso, di deriva affaristica e speculativa. Che sarà stato magari vero, in certi casi. Ma quale meccanismo di pensiero innescò la logica che per rifiutare quella «miseria» (posto che il riformismo sia «miseria») si doveva ricorrere a una scommessa tanto disumana quanto difficile da vincere?
La critica al riformismo, che avevamo ereditato dai gruppi della sinistra extraparlamentare dell’epoca, poteva trovare fondamenti e, di volta in volta, magari ragioni, ma sostanzialmente era espressione di un estremismo spesso stupido e ideologico. E l’estremismo è un piano scivoloso e inclinato. Mi colpì molto un’affermazione di Carol Beebe Tarantelli, che solo due mesi dopo l’omicidio di suo marito da parte delle Br volle entrare in carcere a parlare con noi, con l’area della dissociazione. In quell’occasione disse:
«Ho detto a questi detenuti che ci unisce un pezzo di storia; che io ho fatto un percorso simile a quelli di loro che c’erano nel ’68. E che la mia parte sovversiva l’ho conosciuta anch’io. Un’altra cosa ho voluto dire loro, quando si ostinavano a definire la morte di Ezio “un barbaro assassinio”: che non era giusto parlarne così, perché è barbaro solo ciò che sta al di fuori di noi, quello che ci è del tutto estraneo. Mentre purtroppo la lotta armata non è che l’espressione più estrema di qualcosa che ben conosciamo, l’estremismo ». Una considerazione che molta parte della sinistra ancora non riesce e non vuole fare.
Veniamo a Prima Linea. Lei dice che non faceva solo lotta armata, e che in questo era diversa dalle Br. Vuole chiarire?
Pl, sin dal nome, ha sempre teso a volersi e vedersi come parte interna del movimento, non come organizzazione separata, né tanto meno come partito combattente, come era invece ambizione dei brigatisti, interni a una logica e una cultura terzinternazionalista.
A differenza delle Br, la lotta armata era da noi intesa come uno strumento contingente non come una strategia. Uno strumento che doveva affiancarsi agli altri, alle lotte legali, alle battaglie in fabbrica e sul territorio. Noi non siamo nati con la pistola in mano, siamo nati dalle lotte operaie e sociali. A dispetto delle nostre intenzioni e teorizzazioni, le armi hanno invece fagocitato progressivamente ogni altra pratica e appiattito ogni diversità tra noi e le Br.
A proposito del Movimento del ’77 lei propone una certa equiparazione tra Pci e Br: l’uno non lo capisce, le altre non fanno nulla per capirlo. Per il primo è senz’altro vero, i partiti stentano a capire i movimenti. Per le seconde vorrei capire io. Non erano anche le Br, pur con la loro «boria» di partito, parte di quel movimento? Figlie, quantomeno, di una scelta ribellistica che travolgeva tutto?
Le Br, volendosi appunto come partito, avevano in sommo disprezzo il movimento, visto solo come «serbatoio» da cui attingere quadri, nel quale arruolare militanti. In quell’ottica, la crisi del movimento era funzionale al rafforzamento del partito. Ed è quello che puntualmente avvenne all’indomani del rapimento e uccisione di Moro. Quel movimento non era certamente pacifista, anzi praticava direttamente forme allargate di violenza e anche di lotta armata. Ma era refrattario a ogni logica di partito e di Stato operaio, che apparteneva alle Br, ma anche al Pci.
Pl, lei dice, non avrebbe mai pensato al sequestro Moro. Che, dice anche, avrebbe reso assolutamente intransigente il Pci e lo avrebbe legato monoliticamente alla Dc. Le chiedo cosa ne pensasse, allora e ora, della questione della fermezza. Era realisticamente possibile agire altrimenti?
Quella della politica della fermezza è stata e continua a essere una questione e una polemica scentrata e sterile, figlia naturale di quella mistificazione sulla nostra identità di cui ho detto prima. L’asse Dc-Pci, già cementato nel compromesso storico, si irrigidì e confermò nella scelta della fermezza, ma penso che una politica diversa avrebbe maggiormente messo in crisi i brigatisti e contribuito e frenare l’incattivimento dello scontro e la deriva del movimento.
Perché Pl uccise Alessandrini? Può riassumere la «logica di allora», che ora lei considera aberrante?
Come ho scritto nel libro e cercato di argomentare con documenti dell’epoca, anche della stessa Magistratura democratica, la logica che ci portò a uccidere Alessandrini, e che ora avverto come terribile e terribilmente sbagliata, era quella che vede e vuole il riformismo come il peggiore e più insidioso dei nemici di ogni istanza radicale e rivoluzionaria. Il Pci e quelle parti della sinistra che si «facevano Stato» era per noi la dimostrazione di un tradimento, oltre che un pericolo concreto. È la logica stalinista del «socialfascismo », che tanto spazio e corso ha avuto nel Novecento, che noi avevamo in qualche modo ereditato e introiettato.
Lei dice: cominciammo a perdere quando le nostre azioni (di Pl e delle Br) furono assimilate al terrorismo. E certo pensa che la definizione era errata. Semplicistica. Ma, realisticamente, potevano, azioni come il sequestro Moro con lo sterminio della scorta, non essere considerate terroristiche?
Credo vi sia un problema di proprietà e pertinenza delle parole. Il terrorismo, va da sé, ha come strumento e al contempo come obiettivo quello di intimorire e colpire indiscriminatamente. La nostra azione non ebbe queste caratteristiche e intenzioni, a differenza dello stragismo e, per stare ai giorni nostri, delle azioni che da ultimo caratterizzano alcune lotte di liberazione, come quella dei palestinesi. La lotta armata che noi portammo avanti, almeno inizialmente era tesa invece a cercare consenso: ad esempio tra gli operai, colpendo i capireparto o i dirigenti più invisi oppure colpendo poliziotti o esponenti fascisti dopo che studenti erano stati uccisi in piazza dalle forze dell’ordine o per la strada da neofascisti: i primi due omicidi di Pl, quello dell’esponente del Movimento sociale italiano, Enrico Pedenovi, e del brigadiere Giuseppe Ciotta, rispondono a quest’ottica: esercitare una giustizia alternativa a fronte della giustizia di classe e della costante impunità dei fascisti e di poliziotti e carabinieri. Una logica tragica e distorta, ma non è definibile terroristica. Diversamente, in una fase successiva venne meno lo sforzo della ricerca del consenso e prevalse lo scontro diretto con lo Stato: le nostre azioni, e ancora di più quelle delle Br, divennero tese a creare spaccatura e schieramento, non a convincere, non a conquistare proseliti. La vicenda del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro e della sua scorta, da questo punto di vista costituirono un punto dirimente. Innescò un’involuzione ancora più tragica, a quel punto inevitabile: la logica delle armi finisce sempre per soffocare e annichilire la politica, la proposta. È solo distruttiva. Le parole, però, non sono mai innocenti e neutre. Basti badare al fatto che gli ex militanti della sinistra armata sono sempre etichettati come terroristi sanguinari, mentre, ad esempio, i repubblichini, autori di tante stragi e deportazioni, sono regolarmente definiti benevolmente «i ragazzi di Salò», mentre la rivolta di Reggio Calabria del 1972, che ha provocato tante distruzioni, attentati, morti e feriti, capeggiata dai «Boia chi molla» di Ciccio Franco, poi senatore del Msi, viene storicizzata con il nome di «Moti».
Come giudica la scarsissima conoscenza dei giovani d’oggi riguardo al terrorismo? È indifferenza, o è un altro dei segni della scarsa cultura complessiva?
Debbo dire che proprio i riscontri che ho sul mio libro, le mail che ricevo da ragazzi che allora non erano nati mi dice che se è vero che c’è scarsa conoscenza – e questo mi pare indicare l’utilità di scriverne – c’è anche voglia di conoscere e discutere di quel pezzo remoto e rimosso della storia italiana. Da parte loro ci sono minori pregiudizi, un atteggiamento mentale più libero, e mi verrebbe da dire più onesto, rispetto alle memorie e alle indignazioni a senso unico che dominano spesso i media e la pubblicistica e anche rispetto ai rancori e alle logiche biecamente vendicative che ciclicamente emergono a partire da talune forze ed esponenti politici.
Ritiene possibile un ritorno della lotta armata? O la vostra esperienza, rivelatasi fallimentare, ha esorcizzato per sempre questa possibilità?
Credo che noi ci siamo assunti lo scomodo ruolo di andare sino in fondo, tragicamente e ottusamente, ma anche coerentemente sino in fondo, ai miti del Novecento, compreso quello della rivoluzione politica violenta, esaurendone ogni plausibilità. Non è però estinto un filone di cultura politica estremistica e anche una logica e una pratica di violenza politica, per quanto ultraminoritaria.


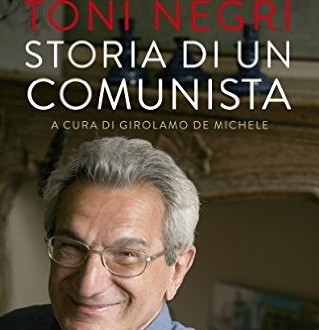


0 comments